l'editoriale
Cerca
Elezioni Usa
04 Novembre 2024 - 18:32
Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti rappresentano sempre un evento di portata globale, ma il voto del 2024 appare destinato a lasciare un segno particolarmente profondo sia per l'America che per l'Europa. La polarizzazione dell'elettorato statunitense riflette una divisione non solo politica ma culturale, che, se consolidata, potrebbe portare a un “suicidio dell'Occidente”, come alcuni analisti hanno definito la situazione attuale. Oggi, più che mai, il risultato delle elezioni rischia di modificare le relazioni transatlantiche e l'architettura politica, economica e di sicurezza costruita nel corso dei decenni quale che fosse il colore politico delle amministrazioni alla Casa Bianca. Dal secondo Dopoguerra, la politica estera americana ha oscillato tra interventismo e isolazionismo, influenzando profondamente la stabilità e la prosperità dei suoi alleati europei. Storicamente, i presidenti democratici si sono distinti per una linea interventista, finalizzata alla difesa non solo degli Stati Uniti ma anche dei valori comuni delle democrazie occidentali. Harry Truman, con il piano Marshall e la creazione della NATO, inaugurerà una stagione di impegno militare e diplomatico che pone le basi per l'alleanza atlantica. John F. Kennedy si opponeva a qualsiasi minaccia nei confronti dell'Europa, e i successivi presidenti democratici, da Carter a Clinton, hanno mantenuto questa linea, intervenendo in casi cruciali, in Europa, come nei Balcani.

Anche Barack Obama, pur prediligendo un approccio meno bellicoso, ha mantenuto saldi i legami con l’Europa e ha promosso una cooperazione in aree strategiche come il commercio e la lotta al terrorismo. Con Biden, poi, si è tornati a parlare di “difesa della democrazia” contro le pressioni di regimi autocratici. Nonostante le critiche sulla politica in Afghanistan e la questione ucraina, l'attuale presidente democratico ha riaffermato la centralità dell'alleanza NATO, impegnando gli Stati Uniti nella difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa e nel supporto ai partner europei. Tale politica ha permesso agli alleati europei di continuare a investire in sviluppo piuttosto che in difesa militare, beneficiando indirettamente dell’impegno economico e militare americano. Se l'approccio democratico è stato storicamente orientato al multilateralismo, il Partito Repubblicano ha seguito spesso una linea più isolazionista, che negli ultimi decenni è sfociata in una vera e propria ideologia “America First”, incarnata da Donald Trump. Con l'eccezione di George W. Bush, che dovette rispondere all'11 settembre con la “guerra al terrore”, i presidenti repubblicani hanno mostrato una certa riluttanza ad impegnare risorse americane per difendere interessi internazionali, privilegiando invece l'autosufficienza interna e proteggendo il mercato statunitense tramite politiche commerciali aggressive. Trump ha portato questa politica all'estremo, imponendo dazi anche agli alleati storici come l'Unione Europea e ritirando gli Stati Uniti da accordi multilaterali importanti, tra cui il Trattato di Parigi sul clima e l'accordo nucleare con l'Iran.

Le sue misure protezionistiche hanno avuto un impatto immediato sulle economie manifatturiere europee, come quella tedesca e italiana, altamente dipendenti dalle esportazioni verso il mercato statunitense. Qualora dovesse vincere nuovamente, è probabile che Trump spinga ancora su questa linea, creando una frattura ancora più profonda con gli alleati europei e gettando le basi per una recessione globale, soprattutto considerando le interconnessioni finanziarie emerse in maniera drammatica, con la crisi dei subprime scatenata dalla bolla immobiliare americana. Inoltre la sua politica di acquiescenza opaca con dittatori come Putin rendono la lettura del futuro per l’Europa piena di gravi interrogativi. La divisione tra le due principali fazioni politiche americane non è mai stata così marcata, e ciò riflette una polarizzazione che appare quasi insanabile. Trump, per diversi aspetti molto discutibile, con il suo messaggio diretto e anti-establishment, ha consolidato il consenso tra la classe operaia bianca della cosiddetta “Rust Belt” e tra gli ispanici e gli elettori degli Stati del Sud, che si mostrano meno permeabili alla cultura woke diffusa dalle élite urbane ormai predominanti nel Partito Democratico. Dall'altro lato, i democratici godono del sostegno delle classi dominanti delle grandi città, delle università, dei media e dei settori culturali e dello star system che promuovono l’ideologia LGBTQ e l'agenda woke, che spesso si scontrano con i valori tradizionali di molte comunità che non intendono soggiacere alla dittatura della “politically correctness”.

In questo contesto, l'esclusione dalla corsa alla presidenza di Biden, un presidente percepito come fragile e malato, ha generato un dibattito interno che divide ulteriormente il partito. La figura di Kamala Harris, debole, chiacchierata per le sue posizioni contro la polizia e di lassismo contro il crimine quando era ministra della giustizia nello stato della California, lontana dai problemi della classe media e legata a una visione più woke in politica interna, ha provocato critiche e ripulse anche tra gli elettori democratici, spingendo molti a votare per una combinazione di potere bilanciato (“split vote”), cioè un voto ai democratici per la presidenza e un voto ai repubblicani per il congresso per bilanciare i poteri, ovverossia rafforzare i controllori dell’esecutivo. Le elezioni americane, nel loro impatto sui destini europei, pongono anche un quesito più profondo sullo stato attuale del ceto politico statunitense. I giganti del passato come Kennedy o Nixon avevano una visione globale e un'idea di progresso che sembra mancare ai leader attuali, spesso più attenti ai sondaggi o alle pressioni delle élite digitali di Silicon Valley che ai bisogni reali della nazione. La politica sembra dominata dai miliardari e dai “signori del web” di Cupertino, mentre il legame tra leader e cittadini si è rarefatto.
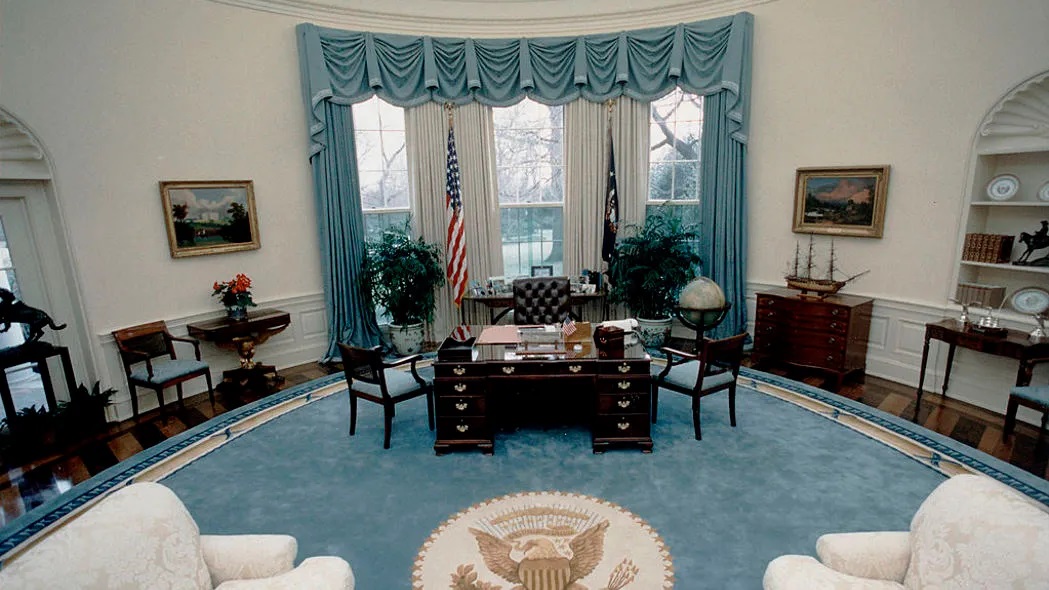
Le idee propugnate dai democratici, sebbene apprezzate da una parte della popolazione, appaiono a tratti eccessive e alienanti per altri, soprattutto quando sfociano in critiche radicali all’Occidente, quando si propugna la “cancel culture” e si abbattono statue e vengono cancellati dai programmi universitari i classici dell’Occidente perché, secondo i nuovi guardiani del politicamente corretto, sono esponenti della cultura bianca, eterosessuale, colonialista, razzista ,etc. Il Partito Democratico, per gli eccessi delle élite che ormai lo controllano, è percepito come promotore di una “ideologia di disarmo culturale”, ha abbracciato visioni che pongono l'Occidente in un'ottica di espiazione. In questo contesto, molti elettori americani e anche diversi osservatori europei temono che l'Occidente stia ormai smarrendo la sua identità e il suo ruolo nel mondo. Per l'Occidente le presidenziali americane non sono solo una sfida interna. Purtroppo né Trump né Harris saranno in grado di ricompattare l’America stante il clima che i due continuano ad alimentare, l’alternativa sembra essere tra la padella e la brace. Le elezioni americane ci mostrano un quadro complesso e inquietante: l'Occidente, diviso al suo interno, finirà per indebolirsi ulteriormente nel confronto con potenze come Cina e Russia, che osservano queste elezioni con interesse e, probabilmente, con un certo grado di soddisfazione. In questo clima di tensione e di incertezza, l'esito del voto americano rischia di non avere vincitori.
I più letti
 L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.
L'associazione aderisce all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - IAP vincolando tutti i suoi Associati al rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e delle decisioni del Giurì e de Comitato di Controllo.
CronacaQui.it | Direttore responsabile: Andrea Monticone
Vicedirettore: Marco Bardesono Capo servizio cronaca: Claudio Neve
Editore: Editoriale Argo s.r.l. Via Principe Tommaso 30 – 10125 Torino | C.F.08313560016 | P.IVA.08313560016. Redazione Torino: via Principe Tommaso, 30 – 10125 Torino |Tel. 011.6669, Email redazione@torinocronaca.it. Fax. 0116669232 ISSN 2611-2272 Amministratore unico e responsabile trattamento dati e sicurezza: Massimo Massano
Registrazione tribunale n° 1877 del 14.03.1950 Tribunale di Milano
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo..